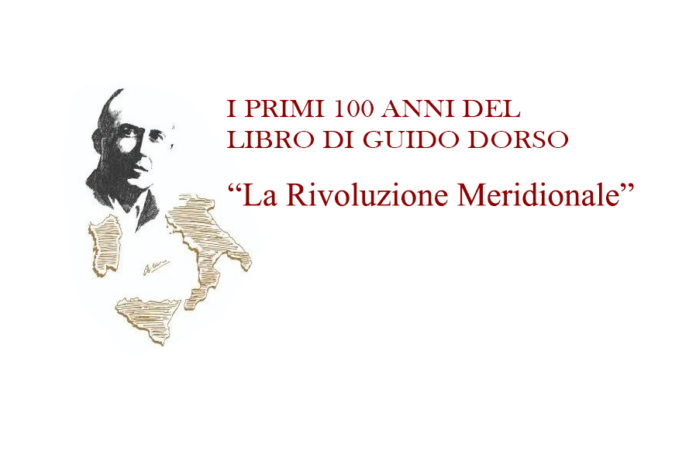Il saggio è stato elaborato in occasione della 45° edizione del Premio Guido Dorso, che ha visto il Prof. Amedeo Lepore assegnatario, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani sede di rappresentanza del Senato della Repubblica italiana, del l’omonimo premio per le sue attività scientifiche e culturali dedicate ai temi dello sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno di Italia. La sollecitazione letteraria, favorevolmente accolta e annunciata nella 45 edizione, nasce dalla volontà dell’Associazione internazionale Guido Dorso di celebrare, con la pubblicazione di un saggio, i cento anni del libro “La Rivoluzione meridionale” di Guido Dorso, edito a Torino nel 1925 dalla casa editrice di Piero Gobetti. La pubblicazione è rivolta soprattutto a far conoscere alle nuove generazioni il pensiero e l’azione dell’illustre meridionalista. N.d.R.
1. La vita di Guido Dorso
Guido Dorso era nato il 30 maggio 1892 ad Avellino. I genitori Francesco Dorso ed Elisa Gallo erano dipendenti pubblici, che svolgevano, rispettivamente, l’attività di direttore delle poste locali e di maestra elementare. Dopo avere conseguito il diploma di liceo classico nel capoluogo irpino, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Napoli, dove erano pregnanti le analisi di Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, laureandosi con il massimo dei voti e la lode nel maggio del 1915, con una tesi dal titolo La politica ecclesiastica di Pasquale Stanislao Mancini. Negli anni dell’adolescenza aveva mostrato un’inclinazione per la letteratura e la poesia, rivelando, poi, un forte interesse per la filosofia politica e un precoce orientamento radicale, democratico e anticattolico. In quella successiva fase, si era avvicinato anche alla massoneria, collaborando con personalità, circoli e riviste ad essa legate, e aveva manifestato uno slancio ideale di tipo volontaristico, già percettibile in un suo articolo del 1909 su Rudolf Christoph Eucken.
Due sue conferenze del 1911 su Giordano Bruno e Giuseppe Mazzini, organizzate dall’Associazione giovanile anticlericale, resero evidenti i fondamenti della sua formazione, durante la quale entrò in contatto con Arturo Labriola, in virtù di una particolare predilezione per gli studi di teoria politica. Poco prima della laurea, si era schierato con il movimento interventista, assumendo una posizione che traduceva questa scelta in una collocazione antigiolittiana, meridionalistica e democratica, con la speranza che il conflitto potesse generare effetti rivoluzionari per il Paese e per il Sud principalmente. Tra gennaio e maggio 1915, scrisse su “Il Popolo d’Italia”, creato a Milano da Benito Mussolini, otto articoli scaturiti dalla convinzione dell’utilità dell’ingresso in guerra, in seguito abbandonata, ma espressione pure del tema portante del risveglio del Mezzogiorno, che lo avrebbe accompagnato per tutto l’arco della sua esistenza. Chiamato alle armi, prese parte alle ostilità come ufficiale di fanteria, ma all’inizio del 1916 venne congedato a causa di complicazioni di salute dovute a un problema cardiaco. Tornato alla vita civile, superò l’esame da procuratore legale presso la Corte d’appello di Napoli e si iscrisse al relativo albo del collegio di Avellino.
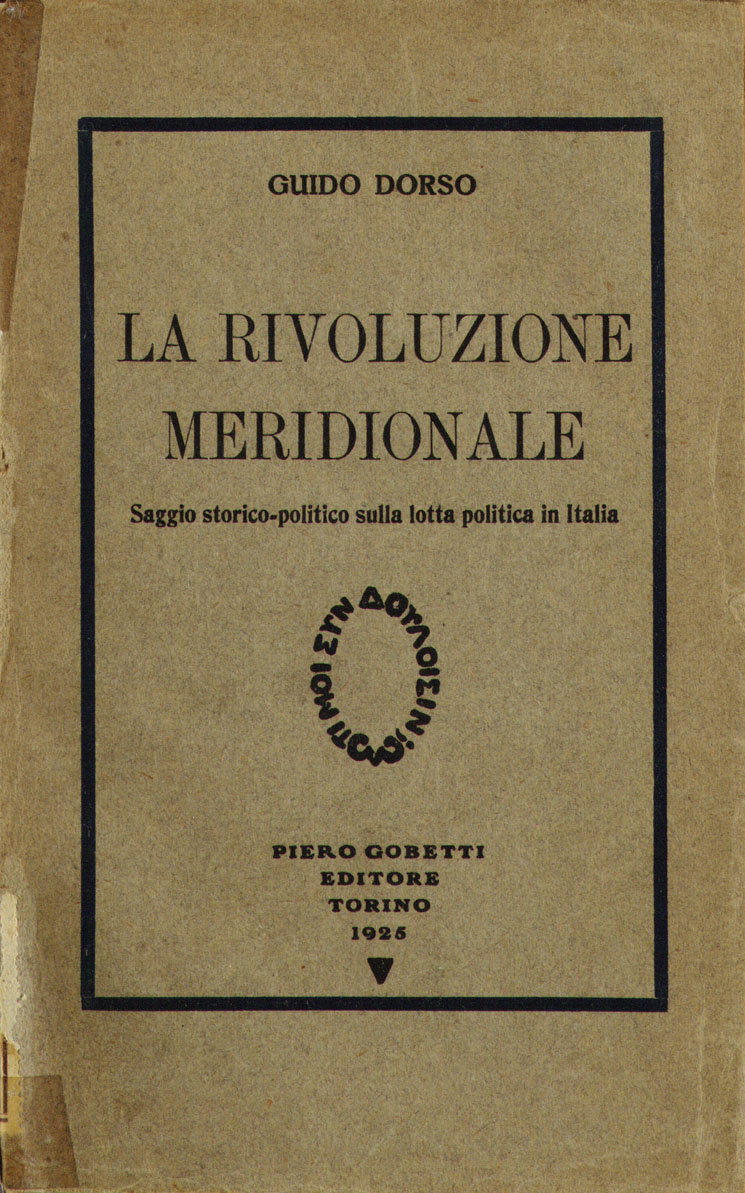
A partire dal 1919, egli si dedicò nuovamente all’attività di pubblicista, lavorando, prima, per “La Libera Parola” e, poi, per “L’Irpinia democratica”, giornale fondato da lui – oltre che da un giornalista del “Corriere della Sera”, suo amico liceale, Augusto Guerriero – e uscito solo per quattro numeri. I temi affrontati in questi anni erano soprattutto di attualità politica, occupandosi specialmente del rapporto tra governo e cittadini nelle regioni meridionali. Nel 1920, Dorso, in preda a uno stato di prostrazione fisica e mentale, interruppe per tre anni l’attività giornalistica. Durante questo triennio, indirizzò il suo tempo unicamente allo studio delle tematiche preferite e alla professione forense, con l’iscrizione al consiglio dell’Ordine degli avvocati del capoluogo irpino, avvenuta nel 1923. In quello stesso anno, riacquistato vigore e maturato il suo pensiero, riprese il progetto editoriale, allargandone progressivamente l’orizzonte da tematiche di livello locale ad argomenti di politica meridionale e nazionale. Nel solco di una vasta riflessione sui limiti della costruzione dello Stato nazionale e di una tendenza a un antifascismo sempre più marcato, egli assunse la direzione del nuovo settimanale “Corriere dell’Irpinia” pubblicato da Armando e Riccardo Pergola, sul quale avrebbero scritto personalità di spicco nel quadro politico e culturale dell’Italia dell’epoca, come Ivanoe Bonomi, Luigi Einaudi, Stefano Jacini, Arturo Carlo Jemolo, Luigi Salvatorelli e Luigi Sturzo.
Gli articoli del “Corriere dell’Irpinia”, che polemizzò con la riforma scolastica di Giovanni Gentile e si concentrò «non nelle adusate combinazioni del trasformismo politico, ma in un’opera di alta educazione collettiva» (editoriale del 3 gennaio 1924), attirarono l’attenzione di Piero Gobetti, che gli scrisse: «seguo con molto interesse e consenso il Corriere dell’Irpinia […]. Sarei lieto di averla come nostro collaboratore». In questo modo, furono avviati un sodalizio tra i due e un proficuo scambio intellettuale basato sui principi liberaldemocratici (1923-1925). Allora, Dorso iniziò a collaborare a “La Rivoluzione Liberale”, che gli offrì un respiro nazionale ed europeo di assoluta importanza e gli permise di ampliare la struttura della sua ricerca oltre lo scenario locale, con diciotto pezzi sulle radici storiche della questione meridionale. Egli curava la rubrica “Vita meridionale”, incarico per il quale aveva risposto alla richiesta di alcuni cenni programmatici da parte Gobetti, precisando che: «Quanto alla proposta di iniziare su R. L. la pubblicazione di una pagina di Vita Meridionale […] non ho difficoltà a confessarle, che, da qualche tempo, […] avevo vagheggiato l’idea di fondare una rivista meridionale. Poiché, per ora, tale idea non è ancora possibile, mi butto disperatamente sulla sua proposta […]: 1° la pagina dev’essere settimanale; 2° intorno ad essa si devono richiamare tutti gli scrittori liberali e liberisti dell’Italia Meridionale; 3° scopo precipuo della pagina dev’essere un’impostazione severa e calzante della questione meridionale […]».
Su questa rivista, il 2 dicembre 1924 lanciò l’Appello ai meridionali, firmato con altri tredici meridionalisti, nel quale cominciava a mettere a fuoco un leitmotiv della sua opera, sostenendo che la «questione meridionale» era «tutta la questione italiana», che andava fronteggiata mediante un netto ricambio di classe dirigente, frutto della costituzione di nuove formazioni politiche. L’analisi di Dorso acquisiva un senso compiuto con la stampa nel 1925, grazie alla piccola casa editrice di Gobetti a Torino, de La rivoluzione meridionale. Saggio storico-politico sulla lotta politica in Italia, che raccoglieva gli articoli e i contenuti sviluppati su “La Rivoluzione Liberale”. In questo volume, egli si poneva criticamente rispetto al processo di unificazione nazionale, alla nascita dello Stato italiano e allo svolgimento della sua storia, valutando in modo negativo le conseguenze che aveva provocato, soprattutto nel Mezzogiorno. La condizione di immobilismo del quadro politico e la lontananza dai centri decisionali delle istituzioni pubbliche della parte più consistente della popolazione non solo aveva determinato un vulnus della democrazia, ma richiedeva una svolta. La rivoluzione doveva partire dal Sud e doveva puntare a un blocco sociale della borghesia intellettuale e progressista con i contadini meridionali, in antitesi alla proprietà latifondistica. Sebbene il testo avesse suscitato una notevole attenzione da parte di un pubblico di lettori colti di varia ispirazione, Dorso ebbe a dolersi del fatto che apparve «eretico a tutti», venendo difeso apertamente solo da Tommaso Fiore, Antonio Gramsci, Luigi Sturzo, Oliviero Zuccarini e dai giornali sardi.
Con la negazione di ogni tipo di libertà e dissenso, per effetto della promulgazione, tra il 1925 e il 1926, delle leggi speciali “fascistissime” (leggi eccezionali), e la trasformazione dello Stato italiano in un regime totalitario con una forte impronta ideologica, di tipo nazionalista, centralista, corporativista e imperialista, venne meno pure la possibilità di proseguire in un’attività giornalistica indipendente. Perciò, alla fine di luglio 1925, egli si dimise dalla conduzione del “Corriere dell’Irpinia”, che, fino ad allora, aveva dato impulso all’evoluzione della questione meridionale, facendola uscire da un’impostazione localistica e rivendicazionista. A novembre dello stesso anno, il settimanale di Gobetti, con cui collaborava, fu costretto a chiudere. Dorso, obbligato a un lungo periodo di “esilio in patria”, dovendo allentare anche le relazioni esplicite con gli altri antifascisti, tornò a dedicarsi all’avvocatura, alle letture e agli studi sui temi da sempre prediletti, di cui si può trovare traccia nei suoi quaderni di appunti. Nell’inverno 1938-‘39 cominciò la preparazione sistematica di un’ampia biografia di Mussolini, data alle stampe nel dopoguerra – per la parte realizzata, che tratteggiava un’esegesi del fascismo come «rivelazione» delle «debolezze costituzionali italiane» – con il titolo Mussolini alla conquista del potere. Peraltro, egli fu radiato dall’albo degli avvocati e dovette ricorrere a un prestanome per l’esercizio della professione di civilista. In quel tempo di difficile isolamento, in cui la Prefettura di Avellino segnalava che egli non offriva «sicura prova di ravvedimento», fu afflitto da problemi di salute e coltivò la passione per la musica e per la radiotecnica, riuscendo a costruire una radio, con cui si collegava a Radio Londra durante la guerra.
Nel 1940, sposò Teresa De Silva, che, due anni dopo, diede alla luce la figlia Elisa. Con la caduta del fascismo e l’armistizio del 1943, egli riprese pienamente l’impegno politico, aderendo al Partito d’Azione – dopo avere partecipato all’esperienza di Giustizia e Libertà – ed entrando a fare parte dell’esecutivo di questa forza politica, e quello pubblicistico, andando a dirigere “Irpinia Libera” e collaborando a “Il Nuovo Risorgimento”, “La Voce”, “La Rinascita” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”. In quegli anni, che costituivano un turning point epocale per tutto il Paese e specialmente per il Mezzogiorno, maturò l’idea di un Sud destinato a cogliere, completando finalmente il percorso risorgimentale di formazione dello Stato unitario, una “occasione storica” di rinnovamento e di riscatto, dopo un passato inglorioso di trasformismo e subordinazione. Questa persuasione lo motivò idealmente nella prosecuzione di una battaglia che non aveva potuto condurre liberamente negli anni del regime. Nel 1944, fu eletto consigliere dell’Ordine degli avvocati di Avellino, dopo la riammissione all’albo. Ma la sua figura era diventata, ormai, molto nota per il valore dell’uomo e dello studioso, oltre che per l’intransigente coerenza quale esponente di rilievo del movimento azionista e, soprattutto, del meridionalismo.
Il 6 agosto 1944 presentò una Relazione sulla questione meridionale al primo congresso del Partito d’Azione tenutosi a Cosenza, mentre, nel dicembre di quell’anno, svolse un intervento su La classe dirigente meridionale al primo convegno di studi sui problemi del Mezzogiorno organizzato dal partito medesimo a Bari. Questi contributi, insieme alla nuova edizione de La rivoluzione meridionale, pubblicata da Einaudi nei mesi seguenti con i giudizi di Sturzo e Gramsci in appendice, lo consacrarono sul proscenio nazionale. Nel luglio 1945, Dorso divenne il direttore de “L’Azione”, espressione degli azionisti meridionali e della loro presenza nel dibattito politico e culturale di quella fase. Gli articoli del quotidiano partenopeo, insieme ad altri sparsi su settimanali e riviste, gli servirono a comporre una miscellanea di scritti politici dal titolo L’occasione storica, edita da Einaudi nel 1949 e suddivisa in quattro aree di interesse: lo “Stato storico”; la questione meridionale; la classe dirigente; la militanza politica. Il giornale, tuttavia, aveva terminato la sua attività nel dicembre 1945 per difficoltà finanziarie e motivi politici, collegati alla fine del governo Parri. A causa di questa vicenda, egli decise di abbandonare irrevocabilmente il Partito d’Azione, che, a suo avviso, aveva rinunciato all’impegno meridionalistico.
Il 2 giugno 1946 si candidò all’Assemblea Costituente, nelle circoscrizioni di Bari-Foggia e di Potenza-Matera, come capolista di Alleanza repubblicana («una concentrazione di raggruppamenti politici repubblicani di centro, che aspirano a sfociare tempestivamente nella costruzione del partito meridionale e meridionalista»), insieme ad altri rappresentanti del movimento azionista meridionale (Manlio Rossi Doria, Michele Cifarelli, Vincenzo Calace, ecc.), senza la riuscita, però, dell’intento di eleggere esponenti della lista per mancanza del “quorum”, nonostante la vittoria dello schieramento nazionale. Questo ulteriore insuccesso lo colpì anche sul piano personale, fino a fargli mutare opinione sul destino dei territori del Sud e a esprimere un sentimento di profondo pessimismo sulla possibilità di compimento della “rivoluzione meridionale”. Dopo il ritorno ad Avellino, Guido Dorso, a causa di un peggioramento delle già precarie condizioni di salute, rifiutò l’incarico di direttore del quotidiano “La Nazione del Popolo”, che in un primo momento aveva accettato su invito di Tristano Codignola e Giorgio Spini. Dopo un ulteriore aggravamento, egli finì i suoi giorni ad Avellino, il 5 gennaio 1947.
Qualche mese dopo la sua morte, Dorso venne commemorato in una manifestazione al Teatro Giordano, nella sua città natale, con la partecipazione di Emilio Sereni, in rappresentanza del governo, del ministro Luigi Cacciatore, di Giorgio Amendola, Tommaso Fiore, Corrado Alvaro, Antonio Flora, Mario Cevelotto, Ugo De Mercurio, Alfonso Rubilli e Salvatore Scoca. In quello stesso giorno, il 20 aprile 1947, Eugenio Reale lo ricordava sulle colonne de “l’Unità”, come una «tra le maggiori personalità intellettuali del Mezzogiorno, uno studioso che dedicò il meglio di sé all’intelligenza della storia italiana e del problema politico meridionale». Reale sottolineava che Antonio Gramsci prese spunto da un testo del grande irpino «per un suo fondamentale saggio sulla questione meridionale». Altresì, affermava che Dorso andava celebrato, oltre che per la sua collocazione nel campo del «liberalismo illuminato […] di quel liberalismo intelligente e progressivo fiorito subito dopo l’altra guerra» e degli «avversari più accaniti del fascismo fin dalle sue origini», anche per il suo contributo «alla rinascita democratica del nostro paese» e all’opera «per staccare i ceti medi dalle concezioni retrive e, specie nel Mezzogiorno, dalle organizzazioni dei vecchi partiti reazionari», saldando, «nella difesa di un comune interesse, […] intellettuali, professionisti, piccoli proprietari, artigiani alle grandi masse operaie e contadine».
Dorso lasciò, a modo di testamento intellettuale, uno scritto singolare ne “L’Acropoli” su Mazzini e la politica dell’irrealtà (1945) e due lavori rilevanti, esito delle riflessioni dell’ultima fase di vita e pubblicati postumi: La dittatura borghese da Napoleone a Hitler e Classe politica e classe dirigente. Entrambi i saggi erano stati redatti, con tutta probabilità, tra l’inverno del 1944-‘45 e la prima parte del 1946, riprendendo argomenti indicativi della sua elaborazione teorica precedente, quali le peculiarità del totalitarismo in epoca contemporanea e una rivisitazione, da un punto di vista democratico, della nozione di élites. Carlo Muscetta, poi, ha curato per Einaudi una importante raccolta delle Opere di Guido Dorso (Torino, 1949-’50), in quattro volumi: Mussolini alla conquista del potere; Dittatura, classe politica e classe dirigente. Saggi editi e inediti; La rivoluzione meridionale; L’occasione storica. Questa pubblicazione ha contribuito a un intenso confronto storiografico, culturale e politico sulla visione e sugli studi di Dorso, che, tuttavia, non ha colmato l’esigenza di approfondire ancora un esteso patrimonio di idee, essenziale per la comprensione della storia d’Italia, della questione meridionale e della responsabilità delle classi dirigenti per la creazione di un divario di sviluppo.
2. La rivoluzione meridionale
L’opera principale di Guido Dorso, concepita tra il 1923 e il 1924 sulla base degli articoli giornalistici e di altri contributi significativi raccolti e riorganizzati dall’autore, era dedicata all’esame della lotta politica in Italia, con l’inserimento della sua descrizione all’interno di un quadro storico definito, che collocava il Mezzogiorno al centro delle vicende nazionali. Il contesto generale era costituito dalla crisi del regime liberale e dalle origini del fascismo, che evidenziavano i limiti dello «Stato accentratore» e il peso di una irrisolta “questione meridionale”, che, anzi, conosceva un acuto aggravamento proprio nel periodo tra le due guerre mondiali. La chiave di lettura di questa analisi era fornita dall’osservazione di un «compromesso» istituzionale e politico favorito da una classe dirigente inadeguata, pronta a reiterare comportamenti trasformistici, senza alcuna forma di ripensamento o novazione. La «rivoluzione» era lo strumento concreto per dispiegare un’azione politica consapevole e coerente, volta all’obiettivo di un cambiamento sistemico, a cominciare da un processo di radicale palingenesi dei ceti dominanti, soprattutto nei territori meridionali.
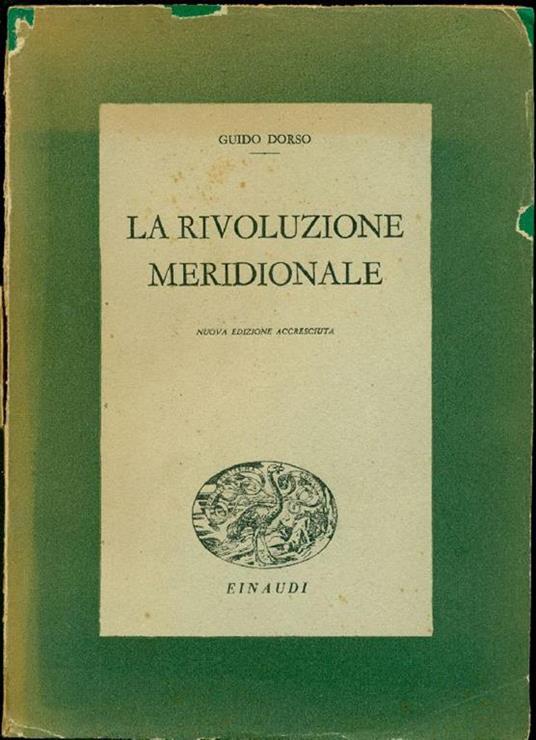
Norberto Bobbio, a proposito dei concetti fondamentali di questo ragguardevole scritto, affini all’elaborazione di Piero Gobetti, ma distanti da quella di Filippo Burzio, notava che: «Dorso, quando parlava di “rivoluzione meridionale”, intendeva parlare di una rivoluzione contadina, guidata da intellettuali liberali e radicali, contro le vecchie clientele responsabili della disperata immobilità del Mezzogiorno. […] L’idea cara al Mosca e al Pareto che la storia fosse esclusivamente opera di élites offriva, da un lato, un criterio di spiegazione della storia d’Italia, quale si era svolta nel più recente passato, e, dall’altro, un’ancora di salvezza per l’opera di rinnovamento. […] Il saggio del Dorso è interessante non solo per il contenuto, ma anche perché è la prima indubbia testimonianza della avvenuta acclimatazione della teoria della classe politica in campo democratico. […] Gobetti e Dorso fanno leva, nella utilizzazione ideologica della teoria, sulla contrapposizione tra un’élite vecchia, che ha ormai esaurito il suo compito, e un’élite nuova, che dovrebbe rinnovare il costume politico italiano, tra un’élite reale, ancorata alle classi padronali, e un’élite ideale, alleata alle classi popolari in movimento. In questa contrapposizione si vede primamente l’innesto della teoria delle élites in una concezione democratica della vita politica».
Sempre Bobbio ricordava che lo studioso irpino aveva inteso tutto il valore della politica come mezzo per l’interpretazione storica, effettuando una disamina della classe dirigente meridionale, in preparazione dell’intervento al convegno del Partito d’Azione sui problemi del Sud, svoltosi a Bari nel 1944. Nel corso di questo approfondimento, Dorso notò che «la formazione di una classe dirigente è un mistero della storia, che né il materialismo né l’idealismo sono ancora riusciti a svelare», osservando che «è compito proprio della teoria politica ricostruire a grandi linee la genesi e la struttura di una classe dirigente». Questa impostazione rivelava una notevole presa su di lui della dottrina di Gaetano Mosca, molto più influente, in questo caso, del pensiero di Vilfredo Pareto. Nel saggio su La rivoluzione meridionale, Dorso mirava alla formazione di un movimento autonomo meridionale capace di rompere il rapporto esistente tra i grandi proprietari terrieri e la media e piccola borghesia urbana, orientando quest’ultima verso le masse contadine, fino ad allora distanti dallo Stato unitario. Il suo scopo era quello di spostare gli strati sociali intermedi, in alleanza con quelli diseredati delle campagne, sul piano dell’impegno contro le politiche che avevano penalizzato il Mezzogiorno con il mancato decollo produttivo dei suoi territori, l’eccesso di pesi fiscali e, soprattutto, la scelta di un protezionismo fortemente dannoso per l’agricoltura meridionale specializzata.
Un altro tema sviluppato nel volume era la scelta dell’autonomismo, ovvero di «un sistema ed un metodo di lotta esclusivamente politico». Dorso, sebbene avesse accolto l’insegnamento di Carlo Cattaneo, filtrandolo attraverso le idee di Gaetano Salvemini, distingueva la sua visione teorico-pratica sia dal puro federalismo sia dal regionalismo in quanto tale, che sono «concezioni che eccedono il campo politico sconfinando sul terreno costituzionale o istituzionale» e, in quel momento storico, potevano rappresentare un impedimento. Occorreva puntare su una modalità più specifica per «completare la rivoluzione liberale del Risorgimento anche a vantaggio delle popolazioni meridionali». Al pari di Salvemini, pure lui considerava il centralismo un malanno endemico della vicenda politica unitaria, che aveva penalizzato duramente il Mezzogiorno. La rivoluzione meridionale, guidata da «cento uomini di ferro», era la base di partenza per un processo di radicale trasformazione dell’Italia. Secondo la convinzione di Dorso: «occorre che i giovani […] escano dallo stato di fatalismo, che incombe sulle anime meridionali, per dimostrare che le élites del Sud non sono costituite soltanto da speculatori geniali capaci di anticipare di secoli le grandi scoperte del pensiero umano, ma cono costituite anche da uomini di azione, capaci altresì di compiere il miracolo di svegliare un popolo di morti». L’autonomia regionale, in ogni caso, come risultava dall’ispirazione repubblicana di Oliviero Zuccarini, avrebbe avuto un ruolo essenziale per combattere l’accentramento statale, spaccare il blocco agrario meridionale e interrompere l’immobilismo politico: «Certo il cammino è lungo e pieno di ostacoli, ma sembra che sia già affiorata una generazione capace di spezzare gli ultimi ceppi del feudalismo. Incomincia anche per il Mezzogiorno l’evo moderno».
Nella riflessione di Dorso era presente la lezione di Giustino Fortunato, con il quale scambiò una amichevole corrispondenza, ma pure la critica rivolta al Risorgimento da personalità quali – oltre Cattaneo e Salvemini – Giuseppe Ferrari, Alfredo Oriani, Mario Missiroli, Giuseppe Gangale e Piero Gobetti, che, a suo avviso, avevano manifestato un’analogia di giudizio, «un residuo teorico comune», sui limiti dell’unificazione nazionale. Il carattere impresso a tale processo da una «conquista regia», che aveva sbarrato la strada alla formazione di una moderna imprenditoria meridionale, portò alla cristallizzazione come forza dominante di un’antica classe agraria, inadatta a svolgere il compito di rinnovamento e svolta necessario al Sud e all’intero Paese. In questa mancanza di una funzione dirigente e in un diffuso malcontento sociale, dopo la prima guerra mondiale, si innestò la crisi del sistema liberale e cominciarono a propagarsi i primi sintomi del fascismo, che avrebbe saldato un’alleanza tra gli industriali del Nord e i latifondisti del Sud. La “questione meridionale” non solo non era stata per nulla risolta, come cercò di sostenere il nuovo regime illiberale, ma assumeva una configurazione di sempre maggiore arretratezza e disparità di condizioni, favorendo la più aspra dicotomia sociale e territoriale, mai conosciuta prima dall’Italia. Si trattava di un problema che non riguardava unicamente l’interno del Paese, ma che si riversava su tutto il continente europeo, nella stagione che si preannunciava di drammatico ripiegamento e chiusura dell’economia internazionale. Lo scritto di Dorso interveniva in una fase ancora iniziale di questa involuzione, nella quale, però, si scorgevano i rischi per la convivenza civile, la democrazia, l’economia e la società italiana, che l’ascesa del fascismo avrebbe significato: le sue premonizioni, non sempre frutto di un ragionamento distaccato, tuttavia, vennero colte da pochi e non servirono a cogliere il pericolo fino in fondo.
3. Gli aspetti storici della politica unitaria e la questione meridionale
La prima parte del volume è dedicata a una ricostruzione storica, che pone al centro dell’attenzione la questione del Risorgimento, osservando come una parte della letteratura sul tema abbia effettuato una sintesi senza prima avere compiuto un’analisi: «alcuni scrittori […] hanno cercato di penetrare il meccanismo interno della formazione unitaria senza aver fatto il processo ad ogni momento di essa». Per Dorso, in quella vicenda non si costituì lo Stato «negli animi dei cittadini […], ma si estese dal Piemonte alle altre regioni italiane, attraverso una serie di aggiramenti, di compromessi, di accorgimenti, che appiattirono la conquistata indipendenza, e scoprirono l’assenza del concetto di libertà come principio rivoluzionario». In questo modo, si riuscì ad ampliare la dimensione geografica dell’Italia, mentre l’orizzonte ideale rimase disagevole e circoscritto. Una responsabilità precipua per il mancato dispiegamento della «rivoluzione» era assegnata a Camillo Benso, conte di Cavour, che «affogò, nello stretto circolo di conservazione della monarchia piemontese, l’incendio romantico del Risorgimento». A differenza di Dorso stesso, alcuni storici difendevano lo statista, asserendo che l’inconsapevolezza e l’impreparazione delle masse popolari non avrebbe permesso di intraprendere altri percorsi per giungere al completamento dell’opera unitaria. Tuttavia, lo studioso avellinese rilevava che la sola dialettica persistente in Italia era quella tra «soluzione storica e necessità ideale. E la rivoluzione […] è sempre diretta a placare una delle necessità ideali rimaste insolute nel processo formativo dello Stato italiano».
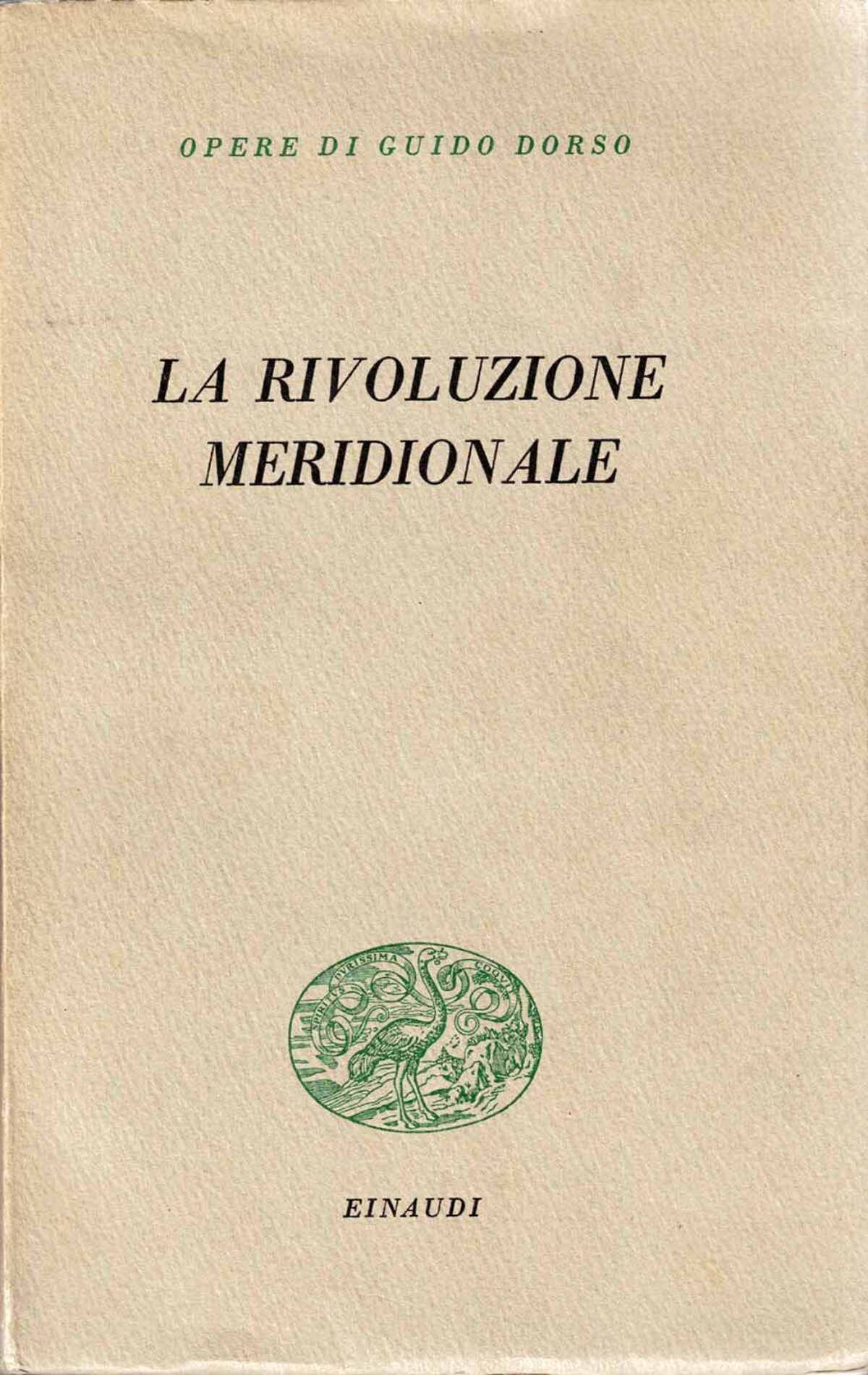
Un aspetto poco evidenziato della valutazione di Dorso, ma molto attuale, riguardava il sistema politico italiano in sé, che si mostrava privo di un «vero e proprio centro di stabilità», mutando configurazione a seconda delle fasi della lotta politica e adattandosi a continui escamotage nel tentativo di alimentare uno spirito di conservazione, nonostante il Paese procedesse verso forme più avanzate di crescita civile. In questa critica, non venivano risparmiati i partiti di opposizione, incapaci di cogliere la necessità impellente di una netta discontinuità, «perché le opposizioni stesse non erano eccessivamente incoraggiate sul terreno dell’intransigenza ideale da l’assenza delle masse». Eppure, dato il progressivo risveglio e inserimento nella vita pubblica di vasti strati sociali, grazie all’evoluzione delle condizioni economiche e culturali dell’Italia, i margini per il loro mantenimento in una posizione di soggezione si sarebbero fatti sempre più ristretti e «a lungo andare non dovranno tardare ad apparire le benefiche conseguenze di questo fatto liberale». Se l’intento, quindi, era di modificare in modo sostanziale il sistema politico nazionale, bisognava «conoscerne a fondo la natura» per individuare le iniziative di radicale rigenerazione da mettere in atto. Dopo una breve analisi del giolittismo, che «dominava il paese, adottando volta per volta le soluzioni minime che gli elaborava il riformismo socialista», e delle altre forze che operavano nel periodo prebellico, suddivise in due gruppi formati rispettivamente dal socialismo anti-riformista e dall’opposizione costituzionale e nazionalista, Dorso si occupava dello scoppio della prima guerra mondiale.
Fu allora quando «tutti gli italiani ebbero l’impressione di essere lanciati improvvisamente nel vuoto», dato che si apriva «una di quelle epoche in cui […] vengono alle luce le deficienze dei regimi e si rimette in discussione lo stesso processo di costituzione dello Stato». Il partito socialista si spaccò tra una «frazione rivoluzionaria», favorevole alla guerra anche come fattore di sovvertimento politico, e «i riformisti», convinti del neutralismo perché ritenevano possibile il rischio di un arretramento, dovuto alle ostilità, dei miglioramenti economici e sociali ottenuti. Anche i partiti «borghesi» si divisero, riguardo al conflitto, ragionando in termini di politica interna, tra il giolittismo conservatore, su posizioni di neutralità, e l’orientamento nazionalista o monarchico, sostenitore dell’intervento bellico. In fin dei conti, così si era determinata una convergenza ideale, sul terreno della finalità di un capovolgimento politico per effetto del conflitto bellico, tra la «sinistra irredentista ed antidinastica» e la «destra conservatrice». In questo scenario, aveva origine la «elaborazione dottrinale del concetto dello Stato nazionale […], il concetto della Nazione, intesa organicamente come ente a sè, e non come conglomerato degli individui che la compongono». Malgrado l’esistenza di un largo fronte neutralista e il fatto che «i consigli giolittiani suonassero assai bene alla maggioranza delle orecchie italiane», l’Italia entrò in guerra e il disordine che derivava da questa situazione del tutto contraddittoria perdurò nel dopoguerra, lasciando la «questione del Mezzogiorno» in disparte.
La rapida diffusione della suggestione del bolscevismo all’interno di diversi strati sociali italiani parve un segnale dell’inadeguatezza della propensione al rinnovamento del Paese, che si limitava allo «sforzo puramente verbale di applicare alla realtà nostra, semifeudale e precapitalistica schemi rivoluzionari astratti, prodotti da altri popoli per differenti realtà sociali ed interpretati dai nostri rivoluzionari in maniera assolutamente arbitraria e anarchica». Inoltre, un altro elemento di debolezza era costituito dalla distonia tra l’esigenza di una rivoluzione politica, capace di adeguare le «istituzioni e la rappresentazione alla realtà economica del paese», e l’ampiezza di un orientamento, influenzato dalle idee provenienti dall’est, che propugnava la necessità di una rivoluzione sociale. Tuttavia, Giovanni Giolitti, pur riprendendo la guida del governo nel 1920 per poco più di un anno, «non riuscì […] a salvare il proprio sistema politico, ed a riproporre gli schemi cui si era affidato vittoriosamente nell’anteguerra». La nascita del partito popolare, che tentava di riportare «il torrente rivoluzionario entro lo schema di idee tradizionali» e di aggregare «gli interessi della maggioranza dei produttori», e la distinzione di posizioni tra massimalisti e riformisti, che misero a confronto, rispettivamente, «astrattismo rivoluzionario» e «astrattismo giuridico parlamentare», ebbero un peso anche nel mancato sbocco «in un atto rivoluzionario» della vicenda dell’occupazione delle fabbriche. Secondo Dorso, in questo modo, svaniva definitivamente «il mito russo» e la cosiddetta «rivoluzione post-bellica» terminava con una sconfitta.
L’ascesa del fascismo prendeva abbrivo da questo insieme di irrisolutezze e fragilità del campo democratico contrapposto e dalla comparsa di una nuova borghesia, «nemica sia del socialismo che del parlamentarismo», pronta a realizzare «per suo conto una vera e propria rivoluzione». Il punto di partenza del movimento fascista fu l’ambiente rurale, «la realtà demografica più distante economicamente e spiritualmente dal movimento operaio». A parere dell’autore, fu l’astrattismo dei rivoluzionari, esercitando una notevole pressione sfavorevole sui ceti medi, ad allontanare questi ultimi dall’utopia sovvertitrice e a spingerli sempre più «nelle braccia della reazione». Lo Stato italiano non era in grado di continuare a fornire garanzie e promuovere azioni concrete di supporto alla piccola borghesia, che in esso si era identificata e che, distaccandosi dal suo riparo, contribuì all’affermazione del fascismo: «Numerose classi di cittadini, fin’allora rimaste immobili, vennero risolutamente spinte sul terreno rivoluzionario, e, deluse dall’azione statale, assorbirono rapidamente tutta la retorica antiparlamentare nazionalista, sognando ritorni dittatoriali». L’avanzata del fascismo, con il sostegno e le sovvenzioni dei «capitalisti nostrani», non fu intralciata dal grido di allarme di uno storico e giornalista di valore, come Luigi Salvatorelli, che rivelò la loro «stolta illusione» di potersene servire a difesa di interessi soggettivi immediati.
Oltre all’appoggio degli industriali, il fascismo fece proseliti tra i funzionari statali alla ricerca di benemerenze; i militari, specialmente in congedo; i «post-combattenti», ovvero i giovani che «non conoscendo per esperienza diretta i dolori e gli orrori dei combattimenti, avevano assorbito dalla psicosi bellica soltanto la parte romantica, l’amore indifferenziato per la patria, l’esaltazione imperialista oltre ogni limite di concretezza, la passione per le avventure e le decorazioni, di tal che credettero trovare nella riproduzione artificiale del fenomeno l’atmosfera da essi sognata». In sostanza, esso fu il frutto di una «immaturità di generazioni ultime» piuttosto che della «maturazione di vere e proprie nuove formazioni politiche», che avrebbe potuto condurre, al contrario, a «un tipo di partito conservatore a carattere moderno». Questa natura del movimento gli consentì di espandersi anche nel «campo proletario», colpito dalla guerra, fiaccato dalla disoccupazione e svantaggiato dal «parassitismo statale». In questo modo, il partito fascista si veniva costituendo sulla base di «un’amalgama informe di forze discordanti e contraddittorie», tentando di conciliare, «in nome del mito della Nazione, interessi proletari ed interessi padronali, produttori e parassiti, rivoluzionari e trasformisti», senza riuscire a fornire soluzione al «problema italiano».
In questa parte del testo, Dorso provava ad analizzare le antinomie e le incongruenze del fascismo, che lo avrebbero inevitabilmente portato a: venire meno a ogni proposito di rovesciamento della monarchia – «la così detta rivoluzione, dunque, doveva essere monarchica o non essere» –; trovare accordi con «tutte le forze della conservazione sociale preesistente», abbandonando ogni velleità di cambiamento e limitandosi a una mera «sostituzione violenta di uomini nelle cariche pubbliche»; mantenere la continuità della pubblica amministrazione, senza neppure iniziare la lotta contro la burocrazia in modo da «disimpegnare […] la vita delle provincie dal prepotere del centro». Perciò, come egli osservava, la concreta politica del regime finì per avvalorare l’opinione diffusa che «il fascismo fosse una pura e semplice reazione padronale e che si potessero interamente trascurare tutti gli altri aspetti della sua formazione». In sintesi, mentre alle origini il movimento era espressione dello «sforzo di liberazione della piccola borghesia», nella fase successiva, cambiando pelle, rappresentò niente altro che «la reazione del capitalismo […] sia ai pericoli economici del proletariato che della stessa piccola borghesia». La condizione di Mussolini, che non rinunciò alla politica «delle due porte aperte», come l’aveva definita Mario Vinciguerra, era singolare: «infatti, non poteva fare la conservazione perché di provenienza rivoluzionaria e non voleva fare la rivoluzione perché prigioniero delle forze della conservazione sociale».

L’autore proseguiva descrivendo la situazione creatasi a seguito dell’approvazione della legge elettorale, delle elezioni – connotate dalla violenza squadristica – e dell’insediamento del nuovo Parlamento, fino al compimento dell’assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, che fece precipitare le cose, costringendo il regime a svelare la propria vera fisionomia. È a questo punto che Dorso introduce la sua riflessione storica sul Mezzogiorno.
4. La “conquista regia”
5. I partiti storici e la questione meridionale
6. Lo Stato storico e la rivoluzione meridionale
7. Conclusioni. L’attualità di Guido Dorso
«La lezione di Guido Dorso di moralità e di rigore è una lezione ancora sferzante e stimolante da cui possono trarre ispirazione le nuove generazioni nell’avvicinarsi alla politica per rinnovarla». È quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad Avellino a conclusione delle celebrazioni per il 60° anniversario della morte di Guido Dorso. («Il rinnovamento della politica – ha aggiunto Napolitano – […] è un tema che dovrebbe sollecitare una riflessione costruttiva, non solo fra tutte le componenti dello schieramento politico ma fra tutte le componenti della società italiana. La soluzione ai problemi, sia delle riforme istituzionali sia del rinnovamento della politica, può avvenire solo passando attraverso l’impegno conseguente delle forze sociali, culturali e politiche […]. Al di fuori di tutto ciò c’è solo la denuncia che, perdendo il senso della misura, può anche diventare controproducente e pericolosa»). Giorgio Napolitano, nel ricevere il Premio Dorso 1998, ebbe a dichiarare: «Dopo 50 anni c’è ancora da imparare da Guido Dorso e soprattutto occorre considerare che nello sviluppo del Mezzogiorno non ci sono soltanto le analisi economiche ma anche i fatti di storia e di cultura».
Intransigenza liberale e repubblicana. Non si può racchiudere in una sola definizione. Né in un’unica tradizione politica precisa. Una forte motivazione morale, ma non solo. Un pensiero del tutto originale, anche con i suoi limiti, nell’ambito della tradizione meridionalistica. Né unicamente questione sociale, né modernizzazione sociale. La critica alle classi dirigenti e l’avvento del fascismo.
Giustino Fortunato e Paolozzi.
L’autonomismo a livello regionale (né federalismo, né regionalismo come tali)
Le élites e la Cassa.
Nuovo paradigma:
In realtà egli cerca di tratteggiare una teoria dell’ideologia politica e delle formule giuridiche connesse ad essa nella quale si fondono sia la sensibilità economicistica tipica del marxismo sia la sensibilità etico-politica dello storicismo liberale. Per cui la formula politica non appare solo come un mero strumento di potere bensì si coniuga con la capacità da parte della classe politica di interpretare e fare proprie le credenze della classe dirigente. Scrive, in conclusione: “Ma sia l’esistenza di molti, anzi forse troppi, ideologi puri nella classe politica, sia la necessità per i veri politici di caratterizzare il tipo sociale cui appartengono, dimostra che la formula politica è tutt’altro che un’ingannevole funzione, ed è invece una potente realtà intorno alla quale si organizza la storia umana. La formula politica che più a lungo ha costituito il titolo di legittimazione del potere della classe politica è stata la teocrazia. Onde la prima distinzione da introdurre nella teoria è quella fra formule teocratiche ed ateocratiche. Nelle società primitive e per lungo decorso di secoli poi si è ritenuto che i capi degli Stati fossero direttamente investiti da Dio dell’onere di governare i popoli.”
Manoscritti sito Centro Dorso
Ruit hora
La capacità di indignarsi e di reagire. Non era affatto un’anima morta Dorso.
Piero Gobetti, L’autobiografia della nazione, Fano (PU), Aras Edizioni, 2016, pp. 169-170: «il torto della concezione del Labriola è di prendere tanto sul serio il fascismo da elevarlo a dignità di reazione capitalistica. Come sarà lecito classificare in una stessa serie la reazione capitalistica americana e il fascismo? Per noi qui comincia l’errore: e si finisce per non intendere che il fascismo è un fenomeno italiano, di immaturità storica ed economica, un riaffiorare di medioevo. In questo senso tra noi “il processo capitalistico” è ancora di là da venire».
«La costituzione economica italiana è ben lungi dall’aver prodotto una classe capitalistica ben selezionata e cosciente del suo compito economico nel processo di produzione. La plutocrazia italiana è, in gran parte, di origine parassitaria ed affaristica, e non ha, perciò, caratteristiche di classe ben definite. Di più i nuclei plutocratici sono un’esigua minoranza rispetto al rimanente dei ceti medio e piccolo-borghesi, che costituiscono l’impalcatura sostanziale della società italiana». La mancata formazione, in Italia, di una vera borghesia capitalistica simile a quella sviluppatasi in altri paesi dell’Europa occidentale non poteva non avere conseguenze ben precise nel processo di costituzione e sviluppo dello Stato. È presente nella sua elaborazione il modello liberale e democratico anglosassone, per cui di contro alle organizzazioni popolari e dei lavoratori, occorreva costruire un partito borghese che accettasse il gioco della competizione e della dialettica democratiche. L’impegno di G.D. nel Partito d’Azione diventa sempre più attento, assiduo, critico; esso si snoda su tre direttrici:
a. battaglia contro il rinascere di un possibile colonialismo nordista;
b. lotta contro il vecchio e il nuovo trasformismo meridionale;
c. intransigenza assoluta contro il prefascismo, il quale “sotto certi punti di vista è anche peggiore del fascismo e, in ogni caso, ne preparò l’avvento”.
Insieme con la sempre presente rivendicazione dell’autonomismo regionale, irrinunciabile presupposto democratico, vanno ricordate le polemiche contro il separatismo siciliano di Andrea Finocchiaro Aprile, contro il riemergere del vecchio notabilato politico e di vecchi personaggi quali Enrico De Nicola e Francesco Saverio Nitti, contro la politica del governo militare alleato, contro la borghesia agraria pugliese, contro la politica della Democrazia Cristiana, tesa a costituire un blocco moderato, nel quale il Dorso intravedeva profilarsi un sostanziale mutamento strategico rispetto alla politica sturziana. Altrettanto pregnanti gli articoli sull’accentramento statale nel Sud e sulle sue concrete articolazioni.
Luigi Fiorentino (p. 75): «Nel 1944-1945 Dorso diceva che il Sud per risorgere deve fare da sé, deve fabbricare da solo il proprio destino. Oggi, aggiornando alla realtà contemporanea il pensiero di Dorso, potremmo dire che il Sud attraverso le sue istituzioni e attraverso i suoi sindaci deve essere in grado di partire dalle proprie debolezze e dai propri gap, quindi dalla consapevolezza di questi perccostruire un’idea di rilancio. Un’idea che da un lato superi il campanilismo e il particolarismo edall’altro sia in grado di individuare alcune linee di intervento strategiche che da sole devono creare i presupposti per lo sviluppo».
Guido Dorso, quando diceva che dobbiamo partire dalla consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre debolezze e fragilità, perché altrimenti corriamo il rischio di redigere soltanto un libro dei sogni. “si sono riuniti per spazzare il terribile pessimismo della solitudine” (citando Dorso nell’Appello ai meridionali), Ma se la gioventù meridionale – questa mirabile gioventù così assetata di giustizia e di verità – non sentirà il pungolo della resurrezione e riprenderà triste e scorata, la dolorosa via dei piccoli impieghi e della dedizione allo Stato violento e accentratore, allora anche i pochi semi che sono nati per caso sull’arido terreno del Mezzogiorno saranno sommersi, e nuovi sistemi di compressione e di sfruttamento risorgeranno dalle ceneri ove ora sembrano sepolti.

Amedeo Lepore è Professore Ordinario di Storia Economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. È docente di Storia dell’Economia e dell’Impresa presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS. È docente di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Fa parte del Dottorato Nazionale in “Osservazione della terra” e del Dottorato di ricerca in “Humanities and Technologies: an integrated research path”. È componente del Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ, del Consiglio Direttivo delle Fondazioni Merita Meridione-Italia, Astrid e ANIMI. Fa parte del Comitato Scientifico dell’Osservatorio per le Risorse Pubbliche istituito presso la Corte dei conti e della Rivista della Corte dei conti. È membro del Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha pubblicato, tra volumi e saggi scientifici, oltre 200 lavori in Italia e all’estero sulla storia economica italiana ed europea, sull’evoluzione dell’economia del Mezzogiorno e della questione meridionale, sulla storia d’impresa, della contabilità e del marketing. I suoi attuali ambiti di ricerca riguardano il processo di globalizzazione, le dinamiche del capitalismo e la recente rivoluzione tecnologica, l’evoluzione della bioeconomia circolare, la storia dei divari e del dualismo economico italiano.